|
"Lectio" del Salmo 122

[Testo
del Salmo]
Nel testo
ebraico questo salmo è intitolato Cantico delle
ascensioni o delle ascesi, dei gradini, delle salite, un
titolo che caratterizza ben quindici salmi (dal 120 al
134), detti pure I canti del pellegrinaggio, raccolti
insieme per servire da cantici del pellegrinaggio a
Gerusalemme.
Nella versione
originale, il 122 è anche il primo dei quindici che viene
attribuito a Davide, insieme ai due successivi (dei rimanenti
uno è ascritto a Salomone mentre per gli altri non ci sono
ipotesi). Certamente c'è un motivo per tale attribuzione, pur
se non si ritiene che essa sia autentica e storica perché il
salmo sarebbe stato composto più tardi, quando il
pellegrinaggio a Gerusalemme era diventato un'abitudine.
In ogni caso, Davide è il fondatore della città e il Salmo
122 presuppone Davide come un personaggio: "Là ha sede
il trono di giustizia, il trono di Davide" (v. 5).
Probabilmente, parlando di Gerusalemme come città
"costruita, salda e compatta", il salmista intende
riferirsi alla città ricostruita dopo l'esilio, che diventa
quindi il vanto e la gioia di Israele.
L'attribuzione del salmo a Davide è comunque fondata, perché
esso testimonia un grande amore alla città costruita da
Davide quale capitale del suo popolo.
Quali sono gli elementi costitutivi del salmo?
Anzitutto notiamo una inclusione, cioè una parola che ricorre
all'inizio e alla fine: casa del Signore, dimora del Signore.
"Andiamo alla dimora del Signore" (v. 1); "Per
la casa del Signore" (v. 9).
È interessante osservare come poi non si parli più di questa
casa, ma piuttosto della città: ciò significa che dapprima
Gerusalemme è vista in particolare come luogo del tempio e
poi anche come città nel suo insieme.
Un altro elemento fondante è la triplice menzione di
Gerusalemme (vv. 2. 3. 6), descritta nelle sue porte, nelle
sue mura, nei suoi baluardi. Appellata tre volte, delineata
con tre caratteristiche e indicata con il pronome
"tu": "alle tue porte", "sia pace a
chi ti ama".
Altro elemento strutturale del salmo è che Gerusalemme è
vista quale luogo di pace. Ben quattro le occorrenze di questo
termine: "domandate pace per Gerusalemme", "sia
pace a coloro che ti amano", "sia pace sulle tue
mura", "su di te sia pace". Il gioco di parole
è evidente: "Gerusalemme" veniva interpretata quale
"città dello shalom", della pace: sia pace
alla città della pace, domandate pace per la città della
pace.
Infine il salmo è caratterizzato anche da altre ripetizioni
che gli imprimono un ritmo poetico, molto bello: le tribù, le
tribù del Signore, i seggi di giustizia, i seggi della casa
di Davide.
Vi cogliamo, pur se non possiamo penetrare a fondo il ritmo
dell'originale, quell'affiato che ne fa un poema, un cantico,
qualcosa che nasce dal cuore e, attraverso ritmi, ripetizioni,
assonanze (sono tante nel testo ebraico) mette in luce
un'anima innamorata di Gerusalemme.
Tenendo conto di questi elementi formali, cerchiamo di capire
la struttura logica del salmo, facilmente suddivisibile
secondo le tappe di un pellegrinaggio.
Un pellegrinaggio viene anzitutto deciso; immaginiamo che il
salmo venga cantato da un gruppo di pellegrini che giungono
alle porte della città. Essi devono fermarsi per sbrigare
alcune pratiche burocratiche previste prima dell'ingresso; si
riposano e contemplano la città. Contemplandola ripensano
all'inizio del cammino, al momento in cui hanno deciso di
partire; è il v. 1, "Quale gioia quando mi dissero:
'Andremo alla casa del Signore"'.
Dopo l'inizio, è immediatamente sottolineato l'arrivo: ora ci
siamo, "i nostri piedi si fermano alle tue porte,
Gerusalemme!" (v. 2).
Al v. 3 Gerusalemme viene contemplata dall'esterno, ammirata
quale costruzione salda e compatta, in cui tutto è unità. È
un riferimento alla città sul monte, che dà l'impressione di
compattezza (sulla roccia), e insieme alla situazione
spirituale della città, salda perché fondata sul Signore,
unificata dallo Spirito di Dio.
Quindi, Gerusalemme è contemplata nelle sue caratteristiche e
nel suo ruolo (w. 4-5). Si tratta di una riflessione a livello
morale: meta di pellegrinaggio, luogo di culto, di lode, di
testimonianza della gloria di Dio, centro amministrativo e
politico: "I seggi del giudizio, i seggi della casa di
Davide", casa a cui fu promessa la perpetuità. Dunque un
centro religioso e un centro politico-amministrativo a cui si
guarda con fiducia per i beni che ci attendono dalla
responsabilità politica che ricade su Gerusalemme.
A questo punto segue la preghiera che può essere pensata a
due cori, partendo dal v. 6: "Domandate pace per
Gerusalemme". Anzi, colui che ha espresso la sua gioia,
magari il capo- pellegrinaggio, rivolge un invito ai compagni
pellegrini: "Do- mandate...". E all'invito risponde
il coro: "sia pace a coloro che ti amano, sia pace sulle
tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi" (v. 7). Il capo,
allora, riprende da solo: "Per i miei fratelli e i miei
amici io dirò: 'Su di te sia pace!'. Per la casa del Signore
nostro Dio, chiederò per te il bene" (w. 8-9). Qui
ritorna l'appellazione a Gerusalemme con il "tu",
come a una persona amica che si incontra e cui si augura il
bene, la pace.
Dunque, due cori, nel senso di un solista e di un gruppo.
Sul tempo in cui il salmo è stato scritto ho già accennato
un'ipotesi: il tempo dopo l'esilio, quando il tempio è
ricostruito e il popolo va in pellegrinaggio alla città
santa, l'unico simbolo rimasto dell'unità di Israele.
"Meditatio"del
Salmo 122 
Per rileggere il messaggio, sono possibili diverse piste,
diverse linee. Ne ho scelte tre: una lettura
storico-esistenziale (messianica); una lettura più
specificamente cristiana; e una terza personale, che riguarda
ciascuno di noi.
Gli elementi di una lettura storico-esistenziale sono i grandi
simboli del cammino umano contenuti nel salmo, che ne fanno
una realtà di tutti i tempi, di tutti i luoghi, di tutte le
culture.
Due sono i principali. n primo è il pellegrinaggio,
menzionato non quale tema specifico, bensì nel suo decidersi,
nel suo compiersi. È un grande simbolo del cammino umano,
della vita dell'uomo e dell'umanità, della vita di tutti gli
uomini e di tutte le donne considerati come collettività. n
simbolo avverte: se la vita umana è colta come
pellegrinaggio, allora essa non è un vagare senza scopo e
neppure una fuga dal paradiso, priva di speranza; al
contrario, è un camminare verso un termine. Questa è già
un'apertura straordinaria per accogliere l'esistenza umana
come una realtà che ha un senso preciso. E quando abbiamo
riconosciuto che tale cammino ha un senso e una meta, scoppia
la gioia: "Quale gioia...".
Gerusalemme è l'altro simbolo, la meta stessa del cammino. Un
simbolo universale perché si tratta di una città, di un
luogo di incontro, un luogo di relazioni molteplici, dove i
diversi si ritrovano. Quindi l'umanità non va verso una
dispersione, una Babele confusa, ma verso un luogo nel quale
tutti si incontreranno, si capiranno, intesseranno rapporti
reciproci.
Questa città è salda, non delude. n tema della saldezza è
il più ripreso dal Nuovo Testamento, che non cita
esplicitamente il Salmo 122 però ne riprende il contenuto:
andiamo verso una città salda, solida, ben costruita,
compatta, dove tutto è unità. Questo è il termine del
cammino umano. Ed è anche il luogo d'incontro armonioso e
aperto con Dio, dove Dio è lodato e dove c'è ordine perché
la legge è fatta osservare, dove c'è il trono di giustizia e
ci sono i seggi del giudizio. L'umanità va verso un luogo
dove la giustizia, quella di Dio, non la nostra, trionfa.
Dove, soprattutto, l'umanità spera di vivere l'ideale della
pace e della sicurezza: "Domandate pace per Gerusalemme,
su di te sia pace e tranquillità nelle tue mura, sicurezza
nelle tue case".
L'umanità è così definita come colei che anela a una tale
città, che va verso di essa e trova speranza nella fiducia di
camminare e di essere condotta alla meta. Una visione quindi
molto positiva, anzi propositiva perché ne derivano molte
conseguenze per il modo di camminare dei popoli.
Da questa visione nasce pure una certa pazienza storica: a noi
spetta di porre le premesse affinché si vada sempre meglio
verso la città armoniosa, unita, capace di lodare l'Eterno,
di vivere l'ordine della giustizia.
Una lettura cristiana ci fa subito pensare a Gesù che ha
vissuto profondamente la gioia del Salmo 122. Già a dodici
anni aveva esclamato: quale gioia ho provato ascoltando i miei
genitori che mi dicevano: andiamo alla dimora del Signore! E
probabilmente l'ha cantato alle porte di Gerusalemme quella
prima volta e poi ogni volta, fino all'ultimo pellegrinaggio
nel quale si avviava piangendo verso la città santa:
"Oh, se tu riconoscessi ciò che giova alla tua
pace!". Anzi, nel testo greco il salmo usa l'espressione erofesafe
de fa eis eirenen (v. 6) ripresa dal Nuovo Testamento: se
tu riconoscessi le cose che riguardano la pace di Gerusalemme.
Dunque Gesù ha cantato questo salmo nella gioia e nella
sofferenza sapendo che la sua sofferenza era parte del cammino
di Gerusalemme e dell'umanità verso la pace.
Partendo dalla lettura che ne ha fatto Gesù, ci domandiamo se
il Salmo 122 risuona anche negli scritti apostolici
neotestamentari. Non mi sono venute alla mente citazioni
specifiche, tuttavia il tema della città salda è molto
presente.
Ef 2, 19-20, 22: "Voi non siete più stranieri ne ospiti,
ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio, edificati
sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti [...] In Gesù
ogni costruzione cresce bene ordinata per essere tempio santo
del signore; in lui anche voi insieme con gli altri venite
edificati per diventare dimora di Dio".
Questo tema è penetrato fortemente nello spirito di Paolo,
che ne fa un simbolo interpretativo della crescita della
comunità cristiana, che è la realtà che viene edificata
come la città del salmo.
L'aspetto di pellegrinaggio verso tale città è però
presente in particolare in Eb 11 e in Eb 12: Abramo ha potuto
partire e lasciare tutto in quanto "aspettava la città
dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio
stesso" (11, 10); "Chi dice così, dimostra di
essere alla ricerca di una patria" (11, 14), pellegrino
sulla terra; "Se avessero pensato a quella da cui erano
usciti, avrebbero avuto possibilità di ritornarvi; ora invece
essi aspirano a una migliore, cioè a quella celeste. Per
questo Dio non disdegna di chiamarsi loro Dio: ha preparato
infatti per loro una città" (11, 15-16).
E ancora:
"Vi siete accostati alla città del Dio vivente, alla
Gerusalemme celeste" (12, 22), ecco la menzione diretta.
Alla città che fa parte delle cose incrollabili:
"Rimangono le cose che sono incrollabili. Perciò
riceviamo in eredità un regno incrollabile" (12, 27-28).
Riassumendo il messaggio del salmo: l'uomo è in cammino,
pellegrino verso una città salda, compatta, nella quale Dio
è lodato, nella quale è la pienezza della pace, una città
che non delude e per cui vale la pena abbandonare le altre
città.
Nella spiritualità del Nuovo Testamento è penetrato inoltre
il pensiero delle moltitudini, di tutte le tribù della terra.
Le moltitudini salgono ora verso tale città, e tutte sono
chiamate "moltitudini del Signore".
Così, la lettura cristiana diventa lettura ecclesiale; la
chiesa non è la meta, la grande città, ma è un popolo in
marcia verso quella città.
Se Israele testimonia "là" la tua gloria, Signore,
se "là" ha sede il trono di giustizia, i nostri
interessi sono veramente là? È il "là" di questa
città verso cui camminiamo il nostro criterio di giudizio
storico? Perché, se è così, allora tutte le altre realtà
sono relative, tutti gli eventi (storici, sociali, politici,
culturali, ecclesiali) vanno valutati tanto quanto rispondono
a un cammino verso la città compatta, pacifica, giusta,
oppure rallentano o fanno deviare il cammino.
Quindi il cristiano, interrogato sulle sue speranze, dovrebbe
rispondere spontaneamente: le mie speranze sono la Gerusalemme
celeste, sono là le mie speranze. È il "là" della
pienezza dell'azione di Dio nel suo popolo, nell'umanità.
La lettura più personale del salmo dà spazio a tante
riflessioni.
Pensiamo ai pellegrinaggi che ciascuno di noi ha fatto a
Gerusalemme e nei quali probabilmente ha cantato, evocato,
recitato il Salmo 122 allorché ha visto le mura della città.
Nella preghiera potremmo ringraziare il Signore per le
esperienze che ci ha donato nei nostri pellegrinaggi, per
quanto ci ha fatto capire su Gerusalemme. Ogni volta che ne
rivediamo le mura, proviamo una fortissima emozione. E se non
siamo mai stati a Gerusalemme, come immaginiamo il
pellegrinaggio verso la città santa, come lo viviamo nella
preghiera?
"Andiamo con gioia!" è parola che esprime la
tensione verso il pellegrinaggio, equivale a dire: sapevo che
sarebbe venuto questo momento e penso a ciò che da sempre ho
desiderato.
Conclusione

|
In quale modo la Gerusalemme di oggi partecipa, nel suo
destino doloroso e tragico, alle benedizioni di Dio, alla
promessa di pace?
Partecipa anzitutto attraverso la nostra instancabile
preghiera per la sua pace, le nostre preghiere per la città
reale e simbolica che conosciamo, di cui tocchiamo le mura:
Sia pace sulle tue mura! |
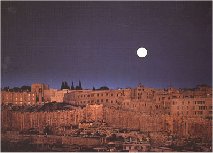 |
Ci domandiamo se e come operiamo per la pace di Gerusalemme,
la cui pace è simbolo, segno, radice e causa della pace di
tante altre città.
Il Salmo 122 ci impegna dunque a pregare e a operare per la
pace nella giustizia.
|